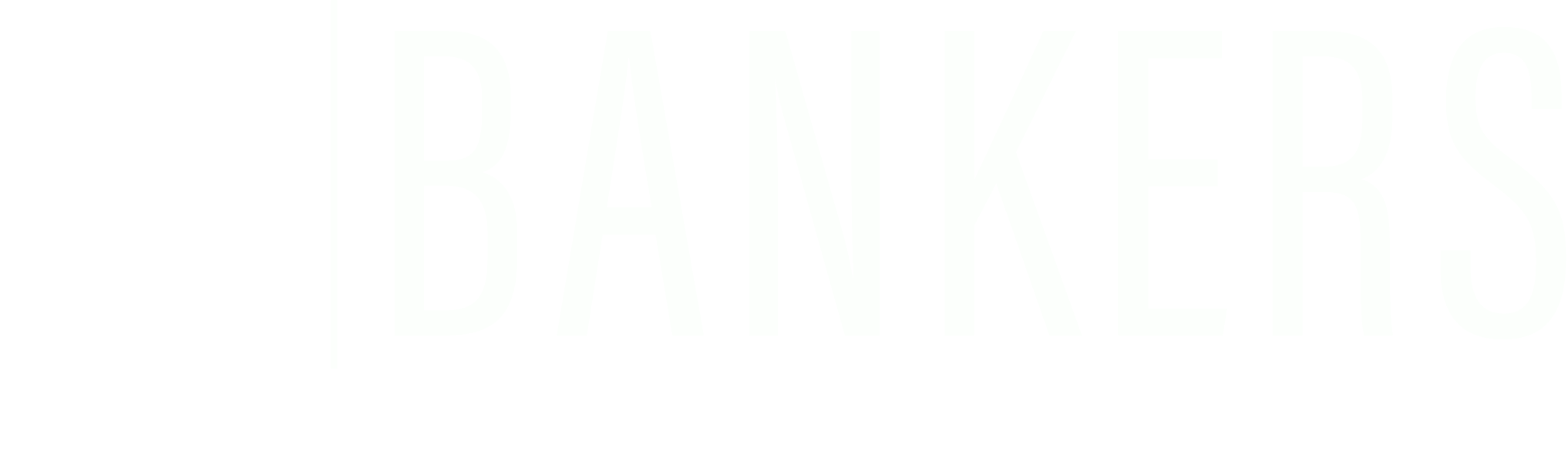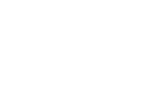L’intelligenza artificiale (Artificial Intelligence, AI) non è una novità nel mondo bancario. Il settore del credito è stato tra i primi ad adottarne pervasivamente le tecniche in ambiti come la valutazione del rischio di credito, i controlli antiriciclaggio e l’individuazione di frodi. Oggi l’AI di nuova generazione – capace di ricevere istruzioni nel linguaggio naturale con cui comunichiamo, pianificare e portare a termine azioni complesse – apre ambiti applicativi del tutto nuovi, che vanno ben oltre l’automazione di attività ripetitive e rigidamente strutturate. È, dunque, fondamentale comprendere, oltre la superficie degli annunci a effetto, cosa cambia con queste nuove tecnologie, cosa resta valido dell’AI tradizionale e come orientarsi nella loro adozione.
Nata nei campus universitari negli anni ’50 dello scorso secolo, l’AI ha conosciuto cicli alterni di entusiasmo e scetticismo sulle proprie potenzialità reali. Il primo approccio affermatosi fu quello simbolico, fondato sull’idea di rappresentare il ragionamento umano tramite simboli e regole logiche, la cui applicazione più diffusa sono i sistemi esperti capaci di raccomandare decisioni sulla base di regole esplicite. Nel settore bancario, ad esempio, questi si affermarono già nei primi anni ’90 nei controlli antiriciclaggio o nella valutazione di piccoli prestiti. Pur offrendo elevata trasparenza nei criteri decisionali, queste tecniche sono limitate dalla rigidità delle regole su cui si basano, che ne impedisce l’adattamento a contesti mutevoli e l’apprendimento dall’esperienza.
Dalla fine degli anni ’90, l’aumento della capacità computazionale e dei dati disponibili (big data) ha favorito la diffusione di un secondo approccio basato su modelli che apprendono dai dati invece di operare secondo regole logiche: il machine learning. Le sue applicazioni tradizionali hanno trovato uno spazio naturale nel settore bancario, caratterizzato da processi standardizzati e dati strutturati, vale a dire codificati e organizzati in formato tabellare. In ambiti come il credit scoring e la rilevazione di frodi e anomalie comportamentali, per citare alcuni esempi, queste tecniche hanno spesso superato i metodi precedenti, offrendo prestazioni predittive superiori grazie alla capacità di rilevare autonomamente pattern complessi dai dati. Tuttavia, i modelli così sviluppati presentano criteri decisionali opachi e restano applicabili a perimetri ben definiti.
Una delle evoluzioni più potenti del machine learning è il deep learning basato su reti neurali artificiali, che ha visto un’accelerazione significativa nello scorso decennio grazie all’innovativo utilizzo di processori grafici per gestire elevati volumi di calcolo in parallelo. Queste tecniche, efficaci anche su dati non strutturati, come testi, audio o immagini, sono alla base della nuova generazione di AI, quella generativa. I suoi modelli non si limitano a classificare o predire, ma producono contenuti originali, quali elaborati testuali, codici informatici o rappresentazioni grafiche, simulando con sorprendente efficacia alcuni tratti della creatività umana. In ambito bancario, promettono di affiancare il personale nelle attività operative e rendere più efficienti le interazioni con i clienti, ma pongono anche nuove sfide. Se non implementate correttamente, ad esempio, queste tecniche possono generare esiti verosimili ma errati, detti allucinazioni. Inoltre, quando impiegate con finalità illecite, la loro capacità di generare contenuti vocali e visivi altamente realistici può compromettere i più recenti protocolli d’identificazione biometrica.
Ciascuna delle tecniche di AI descritte ha punti di forza e limiti specifici che determinano una naturale complementarità tra questi in contesti applicativi avanzati. La loro efficacia, infatti, aumenta significativamente quando vengono integrate per creare agenti intelligenti: applicazioni capaci di pianificare azioni per raggiungere un obiettivo, utilizzare risorse esterne, come dati o applicativi, e coordinarsi con altri agenti. Grazie ai modelli di AI generativa, che permettono loro di trattare dati non strutturati, comprendere il linguaggio naturale e interagire con strumenti digitali esistenti senza necessità d’integrazioni ad hoc, questi agenti possono oggi operare in modo più flessibile e autonomo.
Nel settore bancario, tali capacità abilitano nuovi scenari di applicazione che vanno ben oltre l’ottimizzazione di attività ripetitive e prospettano di poter intervenire su processi più complessi, che richiedono la capacità di adattarsi al contesto e di articolare decisioni su più livelli.
L’esperienza cliente è stata uno dei primi ambiti ad accogliere applicazioni concrete delle più recenti tecnologie di AI. Gli agenti conversazionali intelligenti possono fornire attivamente un’assistenza rapida e precisa sulla base di risorse documentali specifiche, ad esempio durante la richiesta di un prestito. Possono inoltre instradare autonomamente le richieste verso i consulenti più adatti, contribuendo così a migliorare sia la qualità del servizio, sia l’efficienza operativa. Tra i diversi ambiti, inoltre, lo sviluppo software è quello che, ad oggi, sta evolvendo più rapidamente grazie alla capacità dell’AI generativa di tradurre istruzioni espresse in linguaggio naturale in codice eseguibile e viceversa. La sua applicazione sta accelerando notevolmente la scrittura e la manutenzione del software, pur richiedendo specifiche cautele per garantirne qualità e sicurezza.
In aggiunta, alcune sperimentazioni stanno esplorando il potenziale trasformativo di queste tecnologie in processi complessi, come la concessione del credito commerciale. In questo ambito, sistemi di orchestrazione automatica possono coordinare diversi agenti artificiali specializzati in raccolta e analisi documentale, verifiche di conformità e redazione di documenti di sintesi sul merito creditizio. Allo stesso tempo, agenti conversazionali possono affiancare i responsabili nella valutazione del credito, supportandoli nella definizione delle condizioni del prestito e nelle comunicazioni con i clienti. Secondo McKinsey, questo tipo di soluzione potrebbe accelerare il processo decisionale fino al 30%. Si tratta, tuttavia, di applicazioni che necessitano ancora di ulteriori validazioni prima di entrare a regime.
Come per tutte le innovazioni, queste opportunità richiedono il ripensamento non soltanto delle componenti tecnologiche, ma anche degli approcci strategici e di governance. Molte iniziative basate sull’AI generativa e agentica, infatti, restano bloccate allo stadio di progetto pilota e faticano a raggiungere una piena integrazione nei flussi operativi. Per superare questo stallo, è fondamentale integrare l’adozione dell’AI nella strategia complessiva, evitando iniziative isolate e puntando su obiettivi chiari e misurabili. Secondo McKinsey, avviare progetti circoscritti capaci di dimostrare valore in tempi brevi è determinante per generare fiducia e creare le condizioni per una diffusione progressiva dell’AI, in coerenza con la visione di lungo termine. Serve, però, un approccio graduale e strutturato, fondato su solide basi tecnologiche e un’esperienza consolidata nella gestione dell’innovazione, che eviti duplicazioni per mezzo di componenti modulari, basati su tecniche di AI complementari e riutilizzabili in applicazioni via via più ampie e complesse.
Per cogliere interamente il potenziale delle nuove frontiere dell’AI, dunque, occorre un cambio di paradigma a livello organizzativo. Non è più sufficiente puntare su iniziative di automazione isolate, ma è necessario ripensare in maniera olistica e strategica modelli operativi, logiche di processo e meccanismi decisionali. A fare la differenza sarà la capacità d’introdurre trasversalmente queste tecnologie nelle organizzazioni, con pragmatismo, visione e una governance dedita alla guida della trasformazione.
Iscriviti alla newsletter: https://www.bebankers.it/newsletter/