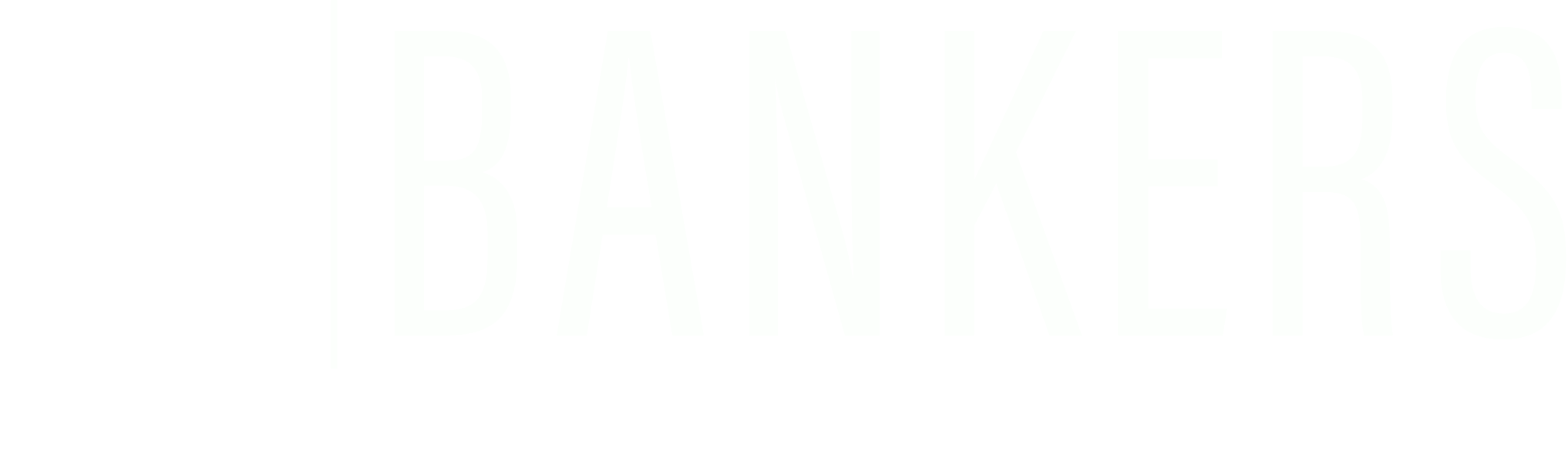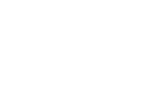L’Europa è costruita sulla burocrazia. Delle tre gambe che compongono l’architettura dell’Unione e nelle quali si articola il suo processo legislativo – sono la Commissione Europea, il Parlamento e la rappresentanza dei singoli governi (il Consiglio) – è senz’altro il primo organismo quello prevalente. Un esercito di 32mila dipendenti che avvia le iniziative legislative e, una volta trasformate in direttive o regolamenti, ne controlla l’attuazione. Come in ogni paese la burocrazia risponde quasi sempre a sé stessa. Ma la debole integrazione europea con una sovranità limitata espressa dal Parlamento e governi con interessi spesso divergenti, ne fanno il vero ago della bilancia dell’Unione. La commissione fa le leggi e le disfa con la stessa incrollabile sicurezza, sempre pronta a giustificare con analisi costi/benefici che spesso contraddicono quelle precedenti i portentosi guadagni delle nuove normative. Peccato che, in assenza di una vera guida politica che interpreti gli interessi della società civile europea, quelle normative mancano spesso di mordente, non hanno «grip».
Una prova viene dal progetto di Capital Market Union (CMU) «rebrandizzato» all’inizio di quest’anno in Savings & Investments Union (SIU). Se l’iniziativa originaria intendeva portare a compimento un mercato dei capitali integrato a livello comunitario, il restyling sottolinea soprattutto la necessità di convogliare i risparmi delle famiglie europee verso investimenti produttivi. È del tutto evidente che il target può essere realizzato soltanto se vi è un efficiente mercato dei capitali, ma l’enfasi ora è posta sul risultato pratico di questo cammino, se effettivamente è in grado di promuovere lo sviluppo dell’Unione. Peccato che i primi esempi della SIU siano deludenti. A fine settembre la Commissione Europea ha rilasciato una raccomandazione volta a favorire «conti di risparmio e investimento con trattamento fiscale semplificato e vantaggioso». La proposta prende spunto dall’esperienza svedese, uno dei pochi paesi del continente in cui in questi anni la borsa è cresciuta e soprattutto è servita a finanziare lo sviluppo delle aziende scandinave più innovative.
Il propellente per lo sviluppo del mercato azionario viene dall’ISK (Investeringssparkonto), un conto di risparmio per investimenti disciplinato dal legislatore. Sugli ammontari depositati in quel conto il governo stabilisce ogni anno un tasso di rendimento standard teorico – supponiamo l’1,5% – che rappresenta l’imponibile assoggettato all’aliquota fiscale (30%). L’imposta è unica e sostituisce tutte quelle previste per i singoli investimenti. L’incentivo è stato ben studiato perché il correntista è spinto a liberarsi della liquidità sul conto ed anche degli investimenti più sicuri (tipicamente i titoli di stato) perché fiscalmente sfavoriti. A trarne vantaggio sono invece gli investimenti più «rischiosi» (tipicamente quelli azionari) ma anche più redditizi. Se quel conto, grazie ad un asset allocation sbilanciata a favore delle azioni, realizza una performance del 10-15%, le tasse non cambiano e lo Stato applica ugualmente l’imposta sulla performance teorica dell’1,5%.
Questo schema virtuoso potrebbe essere riprodotto per l’intera Europa? La risposta è semplice: no. Il motivo sta nel fatto che il fisco è una materia esclusa dalla giurisdizione comunitaria e i singoli paesi hanno piena libertà d’azione nel decidere come tassare i propri contribuenti. Si spiega così il perché il progetto comunitario ha preso la forma, inconsueta, di una raccomandazione in cui si limita ad auspicare che i singoli governi, nel disciplinare i conti di risparmio e investimento, ne favoriscano la diffusione con norme fiscali favorevoli. L’iniziativa, così configurata, lascia un po’ il tempo che trova, sembra il frutto dell’intelligenza artificiale. Intanto, però, consente alle legioni di funzionari di Bruxelles di animare appassionati dibattiti, approfondimenti e analisi d’impatto.
Iscriviti alla newsletter: https://www.bebankers.it/newsletter/