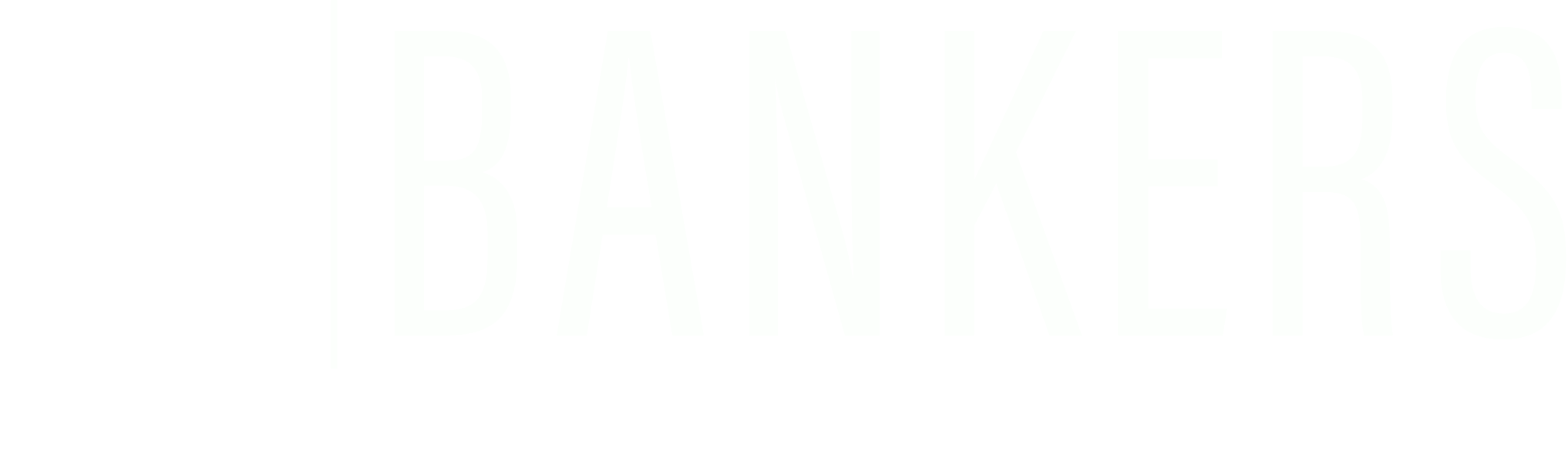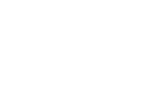«La prossima crisi finanziaria?» è il titolo provocatorio – una domanda senza risposta – dell’Annual Research Conference della Banca centrale europea, organizzata nei giorni scorsi a Francoforte insieme alla Hoover Institution, centro americano di studi economici legato alla Stanford University di California.
Aprendo i lavori della conferenza, il governatore della Bce, Christine Lagarde, non è andata alla problematica ricerca dei potenziali responsabili della futura crisi finanziaria, quanto piuttosto ha indicato la direzione che i regolatori stanno suggerendo per rendere più solidi i mercati finanziari. Le trasformazioni e le nuove tecnologie della finanza – ha spiegato – possono presentare vecchi rischi, anche se in forme differenti.
Dopo la grande crisi finanziaria del 2008, tali trasformazioni hanno rimodellato l’intero sistema finanziario anche in Europa. In primo luogo vi è stata la crescita vertiginosa delle istituzioni finanziarie non bancarie (Nbfi, acronimo in inglese). Nell’area dell’euro, queste ultime (dai fondi di investimento e dalle compagnie assicurative ai fondi del mercato monetario e ai veicoli di cartolarizzazione) sono passate da circa il 140% del Pil nel 1999 a circa il 400% di oggi. Esse rappresentano oltre il 60% del settore finanziario dell’area dell’euro.
Per quanto riguarda il tradizionale settore bancario, i suoi modelli di business sono messi alla prova dall’ascesa delle fintech e dalle stablecoin. La tecnologia amplifica sia la velocità sia la portata con cui i rischi possono materializzarsi. E i tipi di rischio sottostanti – ha detto ancora Lagarde – «sono spesso i soliti noti. I soggetti non bancari affrontano rischi di liquidità e leva finanziaria, le banche affrontano rischi di trasformazione delle scadenze e di esecuzione, e gli emittenti di stablecoin affrontano rischi di rimborso e di riserva».
L’Europa è talvolta accusata di eccessiva regolamentazione. «Ma il ruolo della supervisione e della regolamentazione – ha sottolineato il governatore della Bce – non è quello di frenare l’innovazione o la trasformazione strutturale. Al contrario, è quello di contenere i rischi che possono accompagnare questi cambiamenti. Questo contribuisce a garantire che l’innovazione possa radicarsi e prosperare».
Nel corso della conferenza sono stati suggeriti anche orientamenti nuovi per rendere la finanza mondiale più resistente all’arrivo di un nuovo «cigno nero». «È stato persino suggerito – hanno scritto su Italia Oggi l’ex sottosegretario Antonio Lettieri e l’economista Paolo Raimondi – che in momenti di crisi anche le Nbfi europee possano accedere alle garanzie e ai sostegni delle cosiddette lender of last resort, ai creditori di ultima istanza, come le banche centrali. Attualmente non tutte, ma solo le banche certificate hanno questa possibilità. Di questo passo, presto qualcuno suggerirà che anche gli emittenti delle stablecoin e delle criptovalute abbiano la stessa opportunità, in quanto potenzialmente destabilizzanti per l’intero sistema».
Al riguardo è stato evidenziato che «gli interventi accomodanti, i quantitative easing e altre forme di espansione della liquidità, nei momenti di crisi, possono rendere meno severi gli stress in corso. Ma essi rischiano di gettare le basi per futuri episodi di boom and bust, forti crescite finanziarie seguite da crolli repentini». La liquidità facile «è come la droga, porta a forme di dipendenza. Bassi tassi d’interesse inducono anche a cercare investimenti in asset più remunerativi ma a più alto rischio. Ciò, però, crea anche bolle finanziarie che presto o tardi scoppiano. In tal caso le misure prudenziali non funzionano più, ma servono imponenti interventi di salvataggio del sistema».
Iscriviti alla newsletter: https://www.bebankers.it/newsletter/