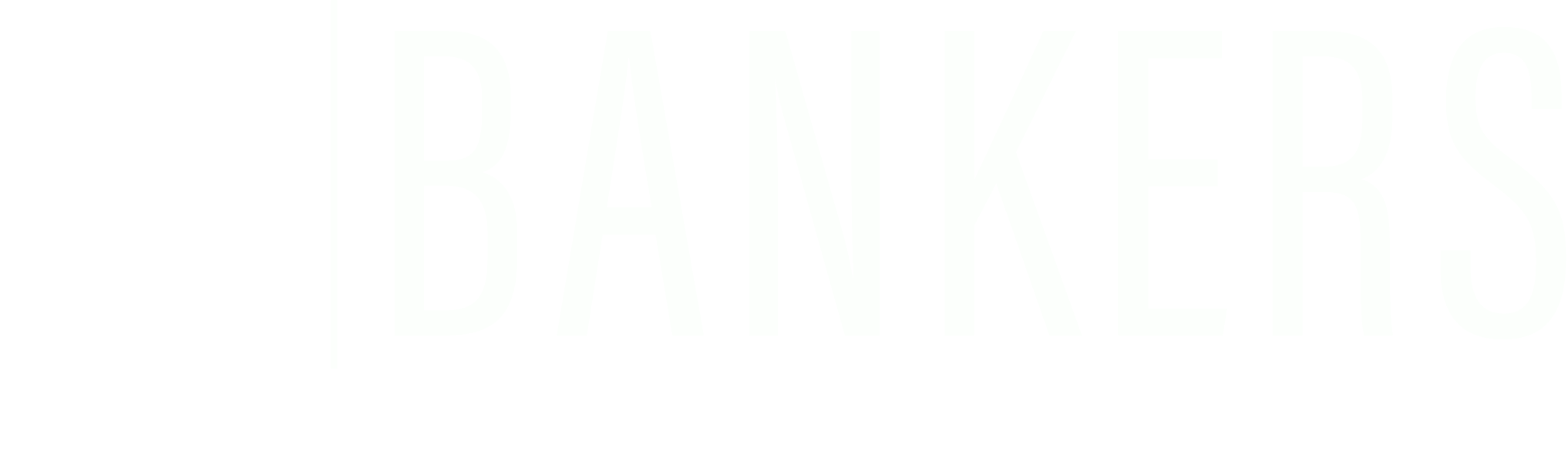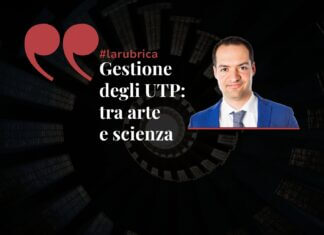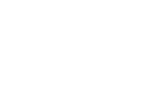Uno degli aspetti più accattivanti di lavorare nella consulenza legale è la possibilità di osservare da un punto di vista privilegiato l’ingegnosità degli operatori di mercato nel ricercare soluzioni creative alle loro sempre mutevoli esigenze commerciali. Molto spesso questa loro vivacità si scontra, però, con le rigidità dei modelli giudici precostituiti dalla legge e la tendenziale vischiosità dell’ordinamento giuridico e, a volte, dei suoi stessi operatori.
È affascinante, peraltro, come il mercato delle cartolarizzazioni e la normativa in materia siano per certi versi eccentrici rispetto a questo quadro. Sarà per il dinamismo del settore o per la natura quasi esoterica di una disciplina ultraspecialistica, questo mercato è fonte di innovazioni sempre nuove.
In questo contributo, si cercherà di raccontare, senza alcuna pretesa di esaustività, di queste più recenti innovazioni, alcune delle quali sono ancora allo stato di feasibility study, altre già parte integrante dell’operatività quotidiana di alcuni player.
Guardando ai punti di intersezione e contatto tra cartolarizzazione e profili immobiliari, uno dei fenomeni che sta assumendo dimensioni rilevanti è quello della trasformazione di società commerciali ordinarie in SPV di cartolarizzazione immobiliare. Presupposto di questo tipo di operazione è che, fin dalla sua costituzione, la società non abbia condotto altra attività oltre all’acquisto dell’immobile da cartolarizzare con annesso finanziamento soci (con esclusione, in particolare, di qualsiasi attività commerciale all’interno dei locali) e che, quindi, si trovi in una condizione, quanto meno nella sostanza, non dissimile da quella di una società di cartolarizzazione immobiliare nel contesto di una c.d. fase ponte.
Seguendo questa impostazione, verrebbe da pensare, peraltro, che, anche a voler tralasciare il mancato adeguamento dell’oggetto sociale al momento dell’acquisto e la mancata registrazione nell’elenco delle SPV nei tempi prescritti dalla normativa regolamentare di Bankit, de minimis ci si aspetterebbe che lo iato temporale tra acquisto e trasformazione ricada in un intervallo coerente con quello di una fase ponte. Quanto alla sua ratio, l’operazione sembra rispondere a un ovvio principio di economicità secondo cui, nel momento in cui si dovesse in queste circostanze valutarsi l’opportunità di realizzare una cartolarizzazione immobiliare, l’ulteriore trasferimento della titolarità del bene immobile ad una diversa società già costituita quale SPV di cartolarizzazione immobiliare ai sensi dell’art. 7.2 della L. 130/99, comporterebbe una fiscalità (in primis, sotto forma di imposta di registro) aggiuntiva e, se si vuole, pleonastica da un punto di vista della sostanza economica in quanto in ipotesi già assolta al momento dell’originario acquisto.
La tematica in questione si sovrappone, quanto meno parzialmente, con l’acceso dibattito in corso in merito alla disciplina fiscale da applicare agli acquisti e alle dismissioni di attivi immobiliari da parte delle società ex art. 7.2, che, come noto, al momento soggiacciono alle ordinarie regole impositive ai fini dell’IVA e delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.
Senza poterci in questa sede addentrare nei dettagli di questo dibattito, basti, ad esempio, segnalare la proposta presentata da Assoimmobiliare nella edizione dello scorso maggio dei suoi «Quaderni», di estendere alle società di cartolarizzazione immobiliare che abbiano conferito a una SGR autorizzata i compiti di gestione e amministrazione del patrimonio immobiliare cartolarizzato ai sensi dell’art. 7.1, co. 8, della L. 130/99, le agevolazioni fiscali già riconosciute a favore degli OICR immobiliari in tema di applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura ridotta della metà per i trasferimenti di beni immobili strumentali.
La logica di questa proposta è quella di uniformare il trattamento fiscale applicabile alle operazioni immobiliari realizzate dalle SGR per conto dei loro investitori a prescindere dalle strutture di investimento (fondo/Sicav vs. cartolarizzazione immobiliare) di volta in volta impiegate. L’iniziativa si segnala anche sotto un diverso profilo, vale a dire per essere espressione di una raggiunta maturità culturale dei gestori di fondi immobiliari italiani che, dopo aver per lungo tempo osteggiato la cartolarizzazione immobiliare come una forma di «concorrenza sleale», hanno finalmente compreso che essa rappresenta uno strumento ulteriore a loro disposizione. Passaggio, questo, che potrebbe segnare il tanto atteso momento di istituzionalizzazione del mercato delle cartolarizzazioni immobiliari a più di un lustro dalla loro introduzione nell’ordinamento giuridico.
Di più ampio respiro appare, poi, l’ulteriore proposta di legge presentata a fine 2024 in occasione dell’iter di approvazione della legge di bilancio che, consapevole della idoneità della cartolarizzazione immobiliare, in presenza di un tranching, a costituire (soprattutto nell’attuale congiuntura restrittiva del credito alle PMI) un valido strumento di finanza immobiliare alternativa al finanziamento ipotecario bancario tradizionale, prevedeva che, al ricorrere di certe condizioni, sia il trasferimento dell’immobile alla società veicolo a costituzione del collateral delle note senior e mezzanine sia la sua successiva retrocessione al prenditore originario (vale a dire al gruppo titolare della tranche junior) una volta rimborsate le predette note, beneficiassero di una tassazione agevolata in misura fissa.
Sempre in tema di innovazioni nel settore delle cartolarizzazioni immobiliari, di grande interesse appare la recente tendenza ad impiegare veicoli di cartolarizzazione immobiliare ex art. 7.2 della L. 130/99 come vere e proprie «reoco», vale a dire società immobiliari a supporto, mediante partecipazione all’asta, del processo di recupero dei crediti oggetto di separata cartolarizzazione per così dire ordinaria.
Fino a qui nulla di che, si potrebbe dire. L’aspetto che assume rilievo nell’ambito di alcune recenti operazioni riguarda la circostanza che i titoli emessi dalla SPV di cartolarizzazione immobiliare vengano sottoscritti dalla stessa SPV di cartolarizzazione di crediti, nel tentativo di ricreare, per quanto possibile, il paradigma del rapporto tra SPV di cartolarizzazione ordinaria e «società veicolo di appoggio» ex art. 7.1 della L. 130/99.
Non a caso, la necessità di impiegare questa nuova configurazione nasce di solito dall’esigenza di supplire all’impossibilità di fare ricorso ad una società veicolo di appoggio essendo i crediti cartolarizzati stati acquistati dal veicolo sul mercato secondario e non già sul primario.
Le voci più caute hanno espresso qualche riserva rispetto a questa impostazione facendo leva ora sul divieto fatto dalla legge alle società di cartolarizzazione di rendersi sottoscrittrici o acquirenti di «titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili» (cfr. art. 1, co. 1-bis, della L. 130/99) ora su un generale divieto di «contaminazione» tra cartolarizzazioni di crediti e cartolarizzazioni immobiliari che si evincerebbe, implicitamente, dal comma 1-ter dell’art. 1 e, in modo espresso, dal primo comma dell’art. 7.2.
Una possibile chiave di lettura alternativa potrebbe invece essere trovata nelle «eventuali operazioni finanziarie accessorie stipulate per il buon fine dell’operazione di cartolarizzazione» di cui alla lett. f) del terzo comma dell’art. 2. A tal proposito, riecheggia nella memoria quel vecchio insegnamento secondo cui la finalità delle operazioni accessorie è, in sostanza, non solo quella di ridurre i rischi del portafoglio ma anche (addirittura) di accrescerli nell’ottica di un rendimento atteso più elevato delle ABS.
Ma se così è, l’operazione in questione sembra ben poter rientrare nell’alveo delle «operazioni accessorie» considerato che, dall’angolo visuale degli investitori nella cartolarizzazione di crediti, essa, per certi versi, attenua i profili del rischio immobiliare sotteso ai crediti (immunizzandolo dalla volatilità tipica dei processi di vendita forzata) mentre, per altri versi, richiede un investimento nei costi di struttura della cartolarizzazione immobiliare in vista di una performance migliore.
Per sfuggire alle suggestioni degli opposti orientamenti, riteniamo dirimente la proposta legislativa sopra richiamata (la cui sostanza è stata poi più di recente ripresa da Assoimmobiliare nei Quaderni) che, nell’adottare una soluzione radicale, supera l’anacronistica distinzione tra crediti cartolarizzati acquistati sul mercato primario e quelli acquistati sul mercato secondario quale criterio di applicazione (o disapplicazione) dell’art. 7.1 (inclusa la disciplina in materia di società veicolo di appoggio).
Sempre nel solco delle novità a cavallo tra cartolarizzazione e aspetti immobiliari, si segnala infine la possibilità – attualmente allo studio di alcuni operatori – che, nel contesto di una «scissione per scorporo» ai sensi dell’art. 2506.10 c.c. di recente introduzione, una società veicolo di appoggio titolare di un immobile in ipotesi non-trasferibile proceda al conferimento di quest’ultimo a favore di una società ordinaria quale beneficiaria, ricevendo, in contropartita, le relative quote, che potranno quindi essere successivamente cedute sul mercato.
La soluzione in questione appare rispondere a legittime istanze del mercato di approntare, per i casi in cui si pongano problemi di trasferibilità dell’immobile, uno schema che ne permetta comunque la dismissione in tempi compatibili con quelli di chiusura dell’operazione di cartolarizzazione, in coerenza con l’oggetto sociale tipico e vincolato di questo tipo di veicolo societario. Né tale soluzione sembra porre seri rischi di incompatibilità con la L. 130/99 se sol si pensi, da un lato, che è lo stesso art. 7.1, comma 4, della L. 130/1999 a prevedere la possibilità per la società veicolo di appoggio di operare per il tramite di ulteriori società veicolo di appoggio e, dall’altro lato, che ove si reputi sufficiente, alla luce delle concrete esigenze, ricorrere a una società ordinaria, questa soluzione presenta un minore grado di innovatività rispetto all’assetto previsto e, se si vuole, autorizzato dalla legge.
In senso analogo sembrano deporre ulteriori considerazioni. Poiché, stando ad una interpretazione autentica offerta dal legislatore nel 2020 a chiarimento della portata della predetta disposizione di legge, le società veicolo d’appoggio possono acquisire i beni immobili a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, anche per effetto di operazioni di scissione, appare lecito pensare che questo stesso strumento possa essere utilmente e legittimamente impiegato dalle stesse società veicolo di appoggio anche ai fini della gestione e della dismissione del loro patrimonio.
Da ultimo, una breve nota a margine di un disegno di legge di recente presentazione, volto a introdurre la possibilità di «cartolarizzare il magazzino». Pur trattandosi di argomento che, a differenza di quelli già oggetto di trattazione in questa sede, non presenta profili immobiliari, a nostro avviso merita attenzione in quanto costituirebbe un’importante innovazione nel settore delle cartolarizzazioni e, più in generale, nel quadro delle iniziative volte a creare canali alternativi di finanziamento per le PMI.
L’intervento segue due direttrici. Per un verso, propone l’ampliamento dell’ambito delle cartolarizzazioni ex art. 7.2 «anche» ai beni (non) registrati. Per altro verso, modifica alcune previsioni dell’art. 7 della L. 130/1999 in materia di operazioni di cartolarizzazione di crediti realizzate mediante l’erogazione di un finanziamento, per includere espressamente tra i crediti cartolarizzati anche quelli futuri (vale a dire, nelle intenzioni, quelli derivanti dalla successiva rivendita dei beni e servizi a cui il magazzino è in qualche modo collegato) nonché i beni del magazzino nel perimetro del patrimonio segregato che rimane nella titolarità giuridica dell’originator.
Tralasciando la tematica (apparentemente irrisolta) delle modalità di identificazione di «beni non registrati» oggetto di segregazione nel contesto dei due schemi ipotizzati, non si può far passare sotto silenzio le perplessità sollevate in merito all’adeguatezza del testo proposto, con particolare riguardo all’intervento da effettuarsi al comma 2-octies dell’art. 7.
Posto che le operazioni di cartolarizzazione dell’inventory realizzate in Italia negli ultimi anni hanno seguito, per quanto noto, lo schema della cartolarizzazione mediante erogazione di un finanziamento, tale struttura può ben essere utilmente impiegata, come è stato fatto in effetti, anche nel contesto di operazioni di cartolarizzazione di portafogli di crediti per così dire ordinari (derivanti da finanziamenti e assistiti da garanzie personali e reali).
Alla luce del wording di cui al disegno di legge, oggetto di segregazione ai sensi del comma 2-octies dell’art. 7 non sarebbero più «i diritti e i beni che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti» bensì «i diritti e i beni all’impiego o alla titolarità dei quali tali crediti siano riferibili, ivi inclusi i prodotti derivanti dalla combinazione e/o trasformazione dei predetti diritti e beni o i beni sostitutivi dei beni precedentemente destinati».
La nuova formulazione appare problematica sotto due profili. Non è certamente chiaro se sia in grado di ricomprendere i «vecchi» diritti e beni che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso dei crediti cartolarizzati (vale a dire quelli già contemplati dalla legge nel testo attualmente in vigore), con conseguente riduzione (e non espansione) della portata applicativa di questa normativa. Ma, in più, non sembra neppure idonea a descrivere con un sufficiente grado di precisione i beni del magazzino e macchinari che si vorrebbero far rientrare, non costituendo, per evidenti limiti espressivi, il richiamo ai «diritti e beni all’impiego o alla titolarità dei quali i crediti cartolarizzati siano riferibili», un criterio di collegamento intellegibile rispetto alla fattispecie astratta ipotizzata.
Pertanto, pur qui ribadendosi l’utilità dell’intervento di cui al disegno di legge, ci si augura che, in fase di adozione, il testo possa essere migliorato al fine di evitare effetti indesiderati.
A conclusione di questo breve excursus, constatiamo con soddisfazione come, per la sua flessibilità, lo strumento della cartolarizzazione continui a dimostrarsi al passo con i tempi e con le istanze di finanziamento da parte delle PMI, soprattutto in un momento congiunturale come quello attuale in cui la contrazione del mercato del credito istituzionale pone la necessità di individuare canali alternativi di finanziamento alle PMI rodati e sicuri, anche in un’ottica di compliance.
Iscriviti alla newsletter: https://www.bebankers.it/newsletter/