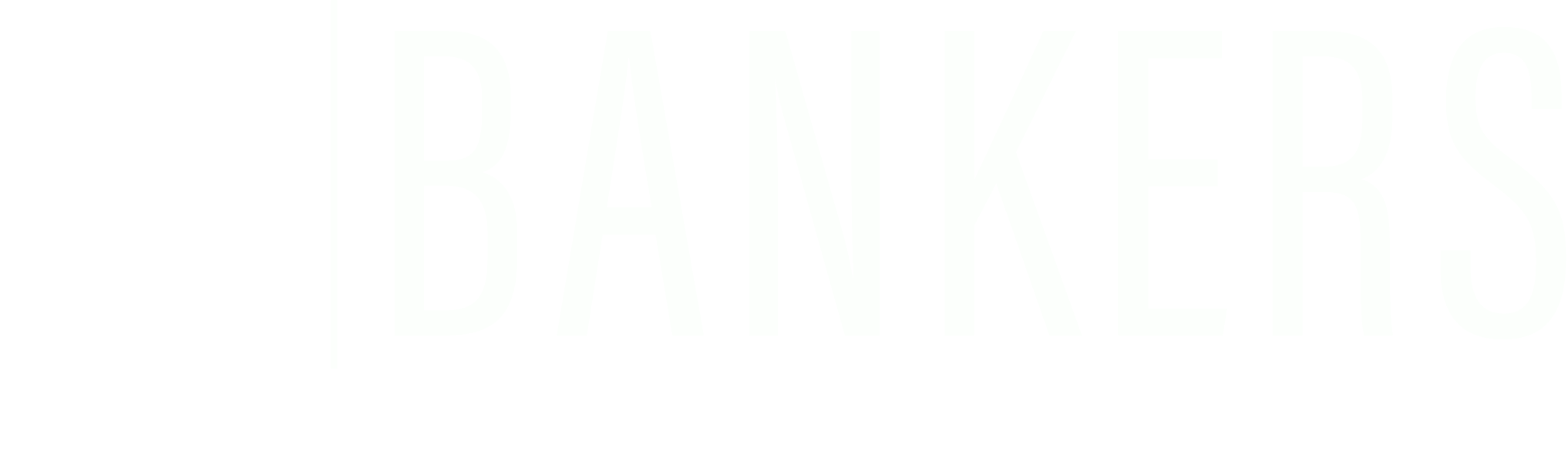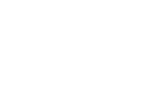L’applicazione di metodologie quantitative allo studio e alla soluzione di questioni giuridiche bancarie e finanziarie sta rivelando pattern significativi nell’evoluzione delle decisioni giudiziarie. Un’analisi condotta su un database di migliaia di quesiti raccolti negli ultimi anni evidenzia come specifiche pronunce giurisprudenziali abbiano determinato cambiamenti misurabili nella prassi dei tribunali. I quesiti raccolti sono formulati dai magistrati nell’ambito di Consulenze Tecniche d’Ufficio in controversie nell’area del contenzioso bancario, in cui gli analisti di Alma Iura sono intervenuti nel ruolo di consulenti di parte.
L’approccio metodologico prevede l’identificazione di momenti di discontinuità temporale nei quesiti, correlati a specifiche pronunce, per misurare l’impatto quantitativo delle decisioni della Cassazione o d’interventi normativi sull’orientamento giurisprudenziale. Tale metodologia consente d’individuare veri e propri turning point nell’interpretazione giuridica attraverso l’analisi statistica della frequenza e tipologia delle richieste dei magistrati.
Uno dei temi più dibattuti e significativi riguarda la verifica dell’usura del tasso di mora e l’individuazione del parametro con cui confrontare tale tasso. La questione si è protratta nel tempo ed è rimasta sospesa fino a pochi anni fa, vedendo contrapposte due correnti giurisprudenziali.
La prima, in assenza di una previsione legislativa, era stata influenzata dalla Comunicazione del 3 luglio 2013 della Banca d’Italia, nella quale veniva specificato che, al fine di evitare il confronto tra tassi disomogenei nella verifica dell’usura degli interessi moratori, i TEGM (Tassi Effettivi Globali Medi) pubblicati devono essere aumentati della maggiorazione media dei tassi previsti per i casi di ritardato pagamento riportata nei decreti ministeriali. Secondo tale orientamento, il tasso di mora poteva quindi essere considerato usurario solamente nel caso in cui superasse il cosiddetto «TSU di mora».
La seconda corrente, invece, sosteneva che non vi fosse alcuna maggiorazione da considerare, in quanto la legge sull’usura imponeva al Ministero la rilevazione dei tassi d’interesse omogenei per tipo di contratto e non per titolo giuridico. Anche la Cassazione aveva inizialmente preso direzioni opposte. Da un lato, la Cass. Civ. III Sez., con Sentenza n. 27442/2018, stabiliva che deve considerarsi esclusivamente il TEGM pubblicato nei Decreti Ministeriali (DM) di riferimento, senza dar luogo ad alcuna preventiva maggiorazione. Dall’altro, la stessa sezione, con Sentenza n. 26286/2019, adottava l’orientamento opposto e sanciva che la soglia usuraria degli interessi di mora va determinata aumentando il TEGM della maggiorazione media indicata nel relativo DM.
La questione è stata finalmente risolta dalla Cass. SS.UU., con Sentenza n. 19597/2020, la quale ha confermato la validità della seconda tesi. I dati raccolti mostrano un cambiamento statisticamente significativo nella tipologia di quesiti formulati dai magistrati dopo il 18 settembre 2020, confermando che l’intervento delle SS.UU. ha segnato un netto cambio di rotta: prima di tale pronuncia, meno del 20% dei quesiti imponeva di tener conto della maggiorazione media dei moratori; dopo, la percentuale è balzata a oltre il 65%.
Un’altra questione che negli ultimi anni ha progressivamente guadagnato attenzione nello scenario del diritto bancario riguarda l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale in presenza di uguaglianza tra il TAN (Tasso Annuo Nominale) e il TAE (Tasso Annuo Effettivo) per gli interessi creditori nei rapporti di conto corrente. L’analisi temporale dei quesiti mostra come questo tema fosse pressoché assente nelle aule di giustizia fino all’Ordinanza della Cass. Civ. VI Sezione n. 4321/2022; da quel momento in poi, però, ha iniziato a imporsi con sempre maggiore frequenza e rilevanza.
In sintesi, la Suprema Corte ha stabilito che, qualora vi sia uguaglianza tra TAN e TAE creditore e sia pattuita la capitalizzazione trimestrale, quest’ultima debba essere comunque eliminata e il saldo del conto ricalcolato. A oggi il tema risulta ancora dibattuto, ma diverse pronunce della Cassazione sono state emesse, confermando la direzione già esposta e affrontata nel 2022. Lo evidenzia l’aumento dei quesiti da parte dei giudici, che vanno in questa direzione e che per oltre l’85% si concentra dopo il 18/02/2022, data di pubblicazione dell’ordinanza.
Un vero e proprio taglio netto che ha inciso sulla formulazione dei quesiti è stato dato anche dalla legge di stabilità del 27 dicembre 2013, che ha modificato l’articolo 120 del TUB in materia di anatocismo bancario, introducendo il divieto di capitalizzazione degli interessi a decorrere dal 1° gennaio 2014. Da tale data, non sarebbe più legittimo che la Banca addebiti in conto gli interessi, facendo così maturare ulteriori interessi sugli stessi.
Parte della giurisprudenza ha sostenuto la non immediata applicabilità della norma, ritenendo necessario attendere la pronuncia del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio), giunta solamente il 3 agosto 2016, con effetto dal trimestre successivo. Col tempo, però, l’orientamento dei Tribunali si è consolidato nel ritenere che il divieto vada applicato già dal 1° gennaio 2014. L’analisi quantitativa conferma questa evoluzione interpretativa: oltre il 65% dei quesiti post legge rivolti ai CTU richiede espressamente il ricalcolo del conto corrente con l’eliminazione della capitalizzazione a partire da tale data. A conferma, è arrivata il 30/07/2024 la Sentenza n. 21344 della Cass. Civ. I Sezione.
L’analisi sul database dei quesiti ha fatto emergere, nel corso del tempo, altre sentenze e pronunce che hanno costituito, a tutti gli effetti, uno spartiacque in ulteriori questioni tecnico-giuridiche. Si pensi, ad esempio, all’intervento della Cass. SS.UU. n. 16303/2018 sul tema della verifica dell’usura in presenza di CMS (Commissione di Massimo Scoperto), stabilendo che quest’ultima debba essere preventivamente confrontata con la CMS soglia riportata nei Decreti Ministeriali. Oppure la Sentenza della Cass. Civ. III Sez. n. 17447/2019, che ha posto fine alla fantomatica sommatoria tra TAN e tasso di mora per la verifica dell’usura erroneamente operata da alcuni Consulenti. O, ancora, la rilevanza ormai assodata delle polizze assicurative tra i costi computabili nel calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), in contrasto con l’orientamento monolitico delle banche.
L’analisi quantitativa dei quesiti giudiziari e del loro mutamento nel tempo costituisce inoltre uno strumento operativo di grande utilità nelle controversie giuridiche; permette infatti, nella maggior parte dei casi, di anticipare le risultanze delle CTU, specie nei casi in cui il Consulente Tecnico d’Ufficio sia già stato incontrato più volte o quando il Giudice del procedimento in analisi aderisca a un preciso orientamento giurisprudenziale.
Si tratta di un aspetto di rilievo strategico, che permette di orientare l’avvocato di parte verso una fruttuosa trattativa, piuttosto che proseguire con le operazioni peritali, laddove l’analisi lasci presagire esiti potenzialmente sfavorevoli. L’incontro tra diritto e strumenti quantitativi offre quindi un vantaggio decisivo nell’affrontare i contenziosi bancari e finanziari.
In un contesto normativo e giurisprudenziale in continua evoluzione, la combinazione di metodo scientifico e competenza giuridica diventa dunque il fattore chiave per trasformare la complessità dei dati in strumenti di tutela e decisione consapevole.
Iscriviti alla newsletter: https://www.bebankers.it/newsletter/