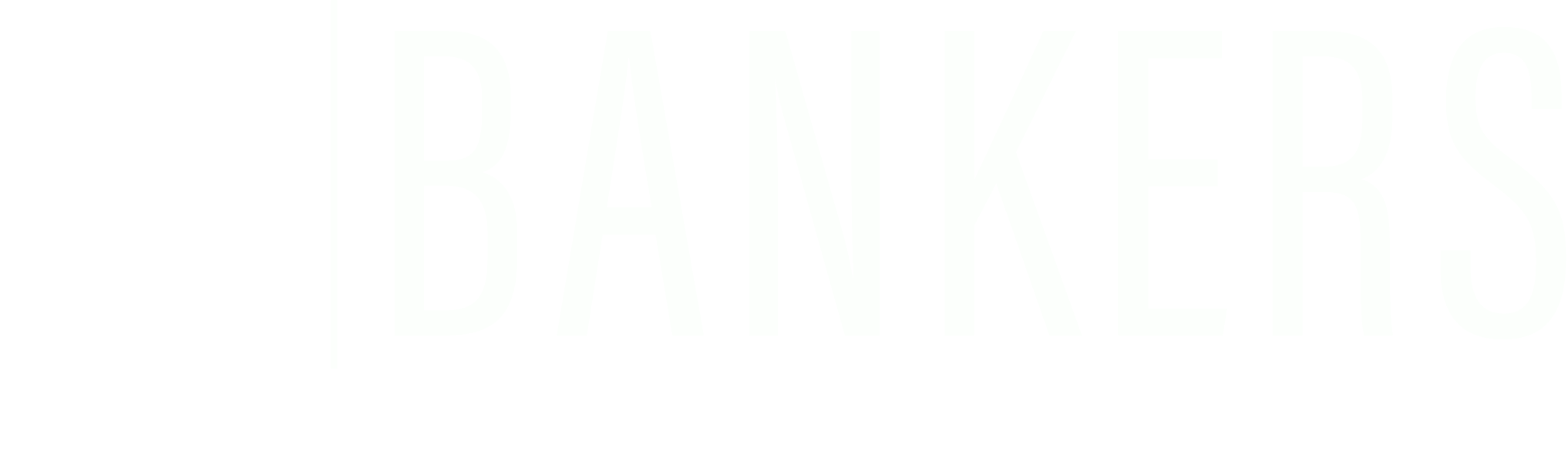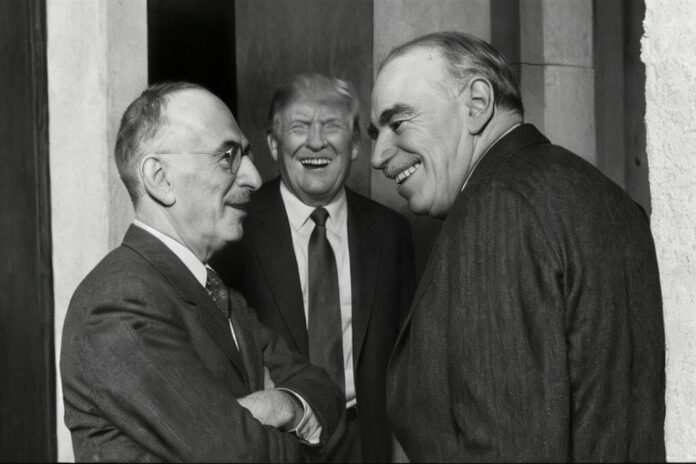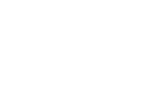C’è qualcosa di tragicamente ironico nel vedere gli Stati Uniti – la nazione che a Bretton Woods affossò le idee di Keynes con una «manina insidiosa» dell’ultimo minuto – ora alle prese con una guerra commerciale che lo stesso economista inglese avrebbe saputo evitare.
La ricetta facile: dazi a pioggia
Trump ha scelto la strada più intuitiva: «se gli altri ci fregano, freghiamoli anche noi». I dazi sono diventati l’arma di elezione, calibrati sul deficit commerciale con una formula tanto semplice quanto brutale: metà del rapporto tra disavanzo e importazioni totali. Un calcolo che l’ISPI ha definito «reciprocità tariffaria», ma che nella sostanza suona più come una rappresaglia.
L’idea di fondo non era neppure malvagia: riequilibrare i conti, riportare a casa la produzione, dare una scrollata a un sistema che sembrava premiare solo chi esportava più di quanto importasse. In alternativa, si parlava di svalutazioni mirate del dollaro, «roba» che ricordava gli accordi dell’Hotel Plaza degli anni Ottanta, quando Reagan fece la stessa mossa per rilanciare le esportazioni americane. Il problema? Che stavolta il mondo non è più quello di quarant’anni fa e il dollaro non è più solo una valuta tra le altre: è la valuta. Indebolirlo significa agitare un fiammifero in una stanza piena di polvere da sparo.
I numeri parlano (e non scherzano)
Non stiamo parlando di manovre cosmetiche. I dazi americani hanno raggiunto una media del 20,1% secondo Wto e Fmi, il livello più alto dal 1910, con l’imposta media sui prodotti importati salita al 18,3%. Le tariffe variano drammaticamente: 15% per l’Europa, 10% per il Regno Unito, fino al 50% per India e Brasile. L’Europa, che se ne stava tranquilla con le sue barriere allo 0,9%, si è trovata improvvisamente nel mirino di una politica commerciale che ha poco di commerciale e molto di bellico. Per l’Italia, le stime parlano di una perdita di PIL tra lo 0,2 e lo 0,3%. Può sembrare poco, ma moltiplicatelo per un’economia da 2000 miliardi e capirete che stiamo parlando di miliardi di euro che se ne vanno in fumo. E questo è solo l’inizio, perché quando parte l’escalation tariffaria, nessuno sa più dove fermarsi.
Il genio incompreso di Bretton Woods
Eppure, c’era stato chi aveva previsto tutto. Nel 1944, mentre a Bretton Woods gli americani imponevano il loro sistema monetario, John Maynard Keynes aveva messo sul tavolo un’alternativa rivoluzionaria: la Clearing Union. Non una banca, ma un meccanismo di compensazione internazionale basato su una valuta virtuale, il Bancor.
Il funzionamento era di una semplicità disarmante: esporti e accumuli crediti in Bancor, importi e li spendi. Ma – e qui stava il colpo di genio – nessuno poteva accumulare squilibri cronici.
Chi andava troppo in surplus si beccava penalità: apprezzamento della valuta, interessi sui crediti in eccesso, obbligo di trasferire risorse a fondi comuni per lo sviluppo. Chi finiva troppo in deficit subiva svalutazioni e interessi passivi. Non si trattava di una moneta unica come l’euro, che sostituisce le valute nazionali, ma di una moneta comune: uno strumento di compensazione che lasciava intatte le sovranità monetarie dei singoli paesi. Era un sistema che penalizzava entrambi gli estremi, perché Keynes aveva capito una cosa – che oggi sembra dimenticata –: i surplus eccessivi sono dannosi quanto i deficit cronici. Chi accumula troppo sottrae domanda al sistema globale, chi spende troppo lo destabilizza. La soluzione non era punire solo una parte, ma riequilibrare il tutto.
L’America che non fu
Naturalmente, gli Stati Uniti del 1944 non ne vollero sapere. La storia racconta che l’egemonia del dollaro fu inserita all’ultimo minuto da una «manina insidiosa», senza che Keynes avesse nemmeno il tempo di leggere l’emendamento che stravolgeva tutto il suo progetto. Avevano appena vinto una guerra mondiale, la loro industria girava a pieno regime, il dollaro era forte come non mai. Perché mai dovevano accettare un sistema che limitava la loro capacità di accumulare surplus? Preferirono imporre Bretton Woods nella versione «dollaro-centrica», che durò fino al 1971, quando Nixon stesso dovette ammettere che il gioco non reggeva più. Ma oggi? Oggi che l’America ha deficit commerciali con mezzo mondo, che la Cina accumula surplus da decenni, che l’Europa barcolla tra austerità e stagnazione? Forse quel vecchio piano di Keynes non suonerebbe poi così male.
Il ruolo cruciale delle banche moderne
C’è però un elemento che né Trump né Keynes hanno completamente inquadrato: il ruolo centrale che le banche commerciali giocano nel sistema monetario contemporaneo. Oggi sappiamo – e persino le banche centrali lo riconoscono ufficialmente – che le banche non si limitano a prestare soldi che hanno già in cassa, come fanno gli altri enti finanziari. Ogni volta che erogano un credito, creano letteralmente nuova moneta. È un meccanismo che funziona attraverso una semplice operazione contabile: concedo un prestito di 100 mila euro e simultaneamente creo un deposito di 100 mila euro sul conto del cliente.
La moneta nasce in quel preciso istante: non esisteva prima. Questa capacità unica di creazione monetaria rende le banche gli attori più influenti del sistema economico moderno, molto più di quanto generalmente si riconosca. Le implicazioni per l’economia globale sono enormi. Se le banche possono creare moneta «dal nulla» (out of thin air), la chiave diventa orientare questa creazione verso investimenti che generino valore reale: infrastrutture, innovazione tecnologica, transizione energetica, ricerca e sviluppo. Il problema sorge, invece, quando questa potente leva viene utilizzata principalmente per alimentare bolle speculative o finanziare acquisti di beni già esistenti, senza aggiungere capacità produttiva all’economia.
Il sistema bancario come architrave del cambiamento
Immaginate di combinare tutto: il sistema di compensazione di Keynes, il potere creativo delle banche moderne consapevolmente orientato, una governance globale che non sia ostaggio dei rapporti di forza del momento. Le banche, con la loro capacità di creare moneta, potrebbero diventare i veri architetti di un nuovo equilibrio mondiale, finanziando investimenti produttivi che colleghino paesi in surplus e in deficit attraverso progetti infrastrutturali e industriali condivisi.
In questo scenario, le banche non si limiterebbero a lubrificare gli ingranaggi del commercio esistente, ma creerebbero attivamente nuovi canali per convertire i surplus di liquidità in capacità produttiva reale, scoraggiando l’accumulo sterile di riserve e favorendo invece investimenti che generino occupazione e crescita sia nei paesi creditori che in quelli debitori. Utopia? Forse. Ma non più utopica dei dazi di Trump, che stanno trascinando il mondo verso una spirale di rappresaglie da cui sarà difficile uscire. E certamente non più utopica del sogno di riportare indietro l’orologio a quando l’America produceva tutto e tutti compravano dollari.
Il rimpianto tardivo
Trump dovrebbe ripensare a quel vecchio economista inglese ogni volta che firma un nuovo decreto sui dazi. Perché Keynes, con le sue idee tanto strampalate quanto lungimiranti, aveva capito che l’economia mondiale è un gioco a somma positiva: o vinciamo tutti, o perdiamo tutti. I dazi sono l’ammissione di aver perso la bussola, di non aver capito che il vero potere nell’economia moderna risiede nel sistema bancario e nella sua capacità d’indirizzare i flussi di credito. Nel breve periodo possono dare l’illusione di proteggere questo o quel settore, ma nel lungo periodo sono come una guerra di trincea: si consumano risorse, si distruggono ricchezze e, alla fine, tutti sono più poveri di prima. Il resto è solo rumore di fondo. E quel rumore, purtroppo, lo sentiranno tutti.
Iscriviti alla newsletter: https://www.bebankers.it/newsletter/