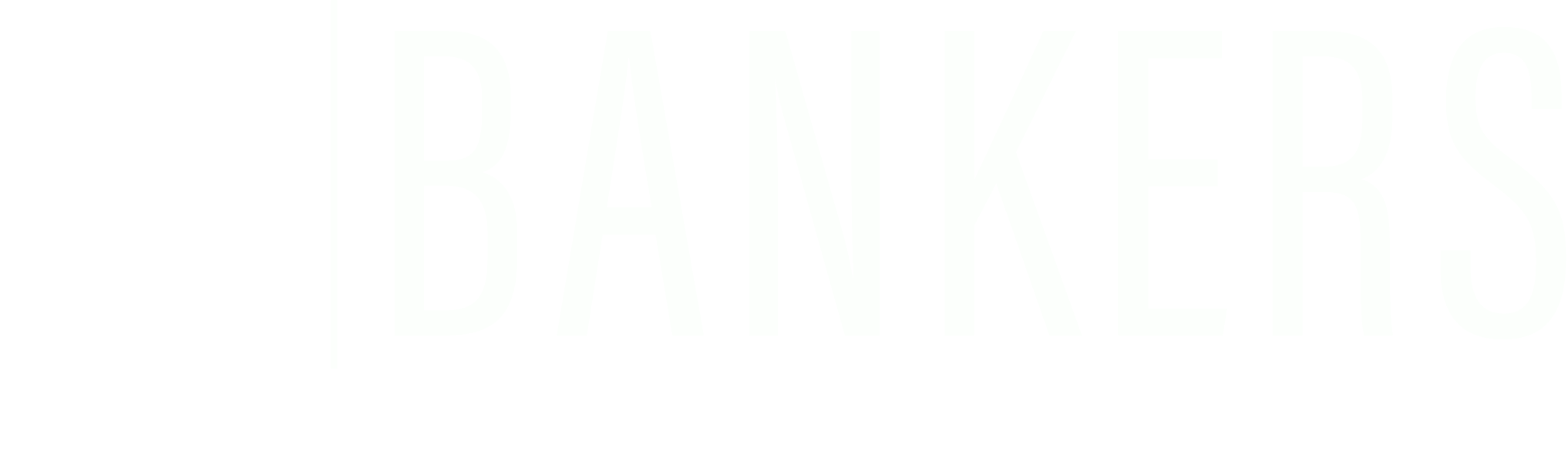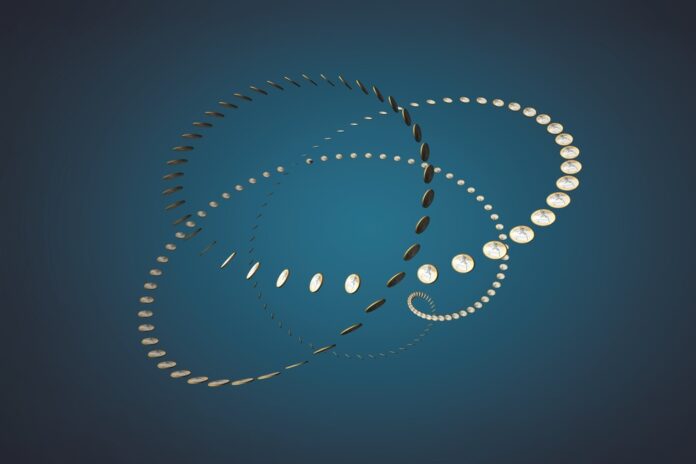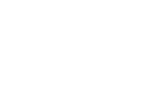Dopo anni segnati da una forte volatilità, il contesto economico globale sta lentamente ritrovando un equilibrio, pur restando esposto a elementi d’incertezza e fragilità.
L’inflazione, che tra il 2022 e il 2023 aveva raggiunto livelli record, ha finalmente iniziato a rallentare, grazie anche all’intervento deciso delle banche centrali attraverso politiche monetarie restrittive. Nell’Eurozona, si è passati da un tasso medio d’inflazione dell’8,4% alla fine del 2022 a valori prossimi al 2% nel giugno 2025, segnando un evidente progresso verso la stabilizzazione dei prezzi. Le prospettive attuali indicano che l’inflazione complessiva dovrebbe mantenersi in linea con l’obiettivo di medio termine della Banca Centrale Europea, pur potendo temporaneamente scendere al di sotto di tale soglia a causa dell’andamento dei prezzi dell’energia, ancora soggetti a dinamiche imprevedibili.
Le previsioni stimano un’inflazione media pari al 2,0% nel 2025, una lieve flessione all’1,6% nel 2026 e un successivo ritorno al target del 2,0% nel 2027, delineando un percorso di normalizzazione graduale, ma ancora non privo di rischi, avvicinandoci al target della BCE.
Nonostante il miglioramento del quadro inflazionistico, il rallentamento dell’economia resta evidente. Secondo l’ultimo consensus di luglio, la crescita del PIL italiano è attesa allo 0,6% nel 2025, dopo un 2024 chiuso attorno allo 0,7%. Per gli anni successivi, le stime restano deboli: +0,8% nel 2026 e +0,9% nel 2027. Un ritmo contenuto, che riflette un contesto ancora segnato da forti incertezze globali: dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente alla fragilità del commercio internazionale, fino ai rischi legati al ciclo politico in Europa e negli Stati Uniti.
A pesare sul quadro domestico è anche l’effettiva capacità di attuazione del PNRR. Secondo i documenti ufficiali del MEF, il contributo del Piano alla domanda aggregata si è rivelato finora molto limitato, risultando ampiamente inferiore rispetto a quanto previsto inizialmente nei documenti di programmazione finanziaria. Nonostante l’Italia abbia rispettato le scadenze iniziali imposte dall’Unione Europea, si registra un rischio di non riuscire a spendere tutti i fondi entro il termine previsto del 2026, specialmente per i progetti più complessi nel Sud Italia. Un segnale chiaro delle difficoltà attuative che stanno frenando il pieno impatto del Piano sull’economia reale.
L’introduzione di dazi generalizzati da parte degli Stati Uniti, pari al 15% sulle importazioni UE a partire dal 7 agosto 2025, rappresenta una criticità rilevante per l’economia italiana. I settori più esposti – meccanica, farmaceutica e agroalimentare – concentrano oltre il 40% dell’export verso gli USA e sono caratterizzati da una forte elasticità della domanda al prezzo. La crescente incertezza legata alle relazioni commerciali transatlantiche ha già avuto effetti tangibili sull’attività economica, rallentando le decisioni d’investimento e comprimendo i margini delle imprese. In questo contesto, è fondamentale monitorare gli sviluppi negoziali tra Washington e Bruxelles, valutando al contempo strategie di diversificazione dei mercati di sbocco e di rafforzamento delle catene di valore europee.
Nel 2024 si sono registrati segnali di miglioramento nelle condizioni di concessione del credito in Italia, grazie al calo dei tassi d’interesse e all’allentamento della politica monetaria. Le banche hanno mantenuto solide posizioni patrimoniali e di liquidità, senza restrizioni sull’offerta. Tuttavia, la domanda da parte delle imprese è rimasta debole, ostacolata dall’autofinanziamento e dal rinvio degli investimenti, con una flessione persistente soprattutto dei finanziamenti a medio-lungo termine.
Nel primo semestre del 2025, la «Euro area Bank Lending Survey» evidenzia una stabilità delle condizioni di credito, con una lieve ripresa della domanda da parte delle imprese, ancora contenuta, e una più decisa ripresa dei prestiti alle famiglie, spinti dal calo dei tassi sui mutui.
Le prospettive indicano una domanda di credito per le imprese contenuta anche nel 2025, frenata da incertezza geopolitico-commerciale e congiuntura europea moderata. Una significativa ripresa è attesa dal 2026, a condizione di politiche monetarie più accomodanti. Per le famiglie, invece, il credito è in espansione già dal 2024 e proseguirà nel 2025 grazie ai mutui più convenienti, seppur moderando la crescita dopo il 2026 a causa di possibili rialzi dei tassi BCE.
In questo contesto, le aspettative sulla qualità del credito restano improntate a prudenza, ma non a pessimismo. La fotografia attuale del credito deteriorato è, tutto sommato, positiva: l’NPL ratio delle banche italiane significant si attesta oggi al 2,3%, ai minimi storici (media UE dell’1,9%) e ben lontano dai picchi del 2014, quando era pari al 17%. I tassi di default sono rimasti contenuti anche nel 2024, attestandosi su una media dell’1,1%, ma le analisi prospettiche indicano un lieve aumento nel biennio 2025–2026, seguito da una moderata riduzione nel 2027.
L’incremento atteso sarà più marcato nei comparti corporate a maggiore ciclicità, come le costruzioni, il retail tradizionale e alcuni segmenti dell’industria manifatturiera. Tale stima, elaborata tramite regressione lineare multivariata dinamica su dati temporali, con elementi di modello autoregressivo (AR) e verifica della stazionarietà tramite test di Dickey-Fuller, si fonda su un approccio misto che integra:
· dati storici di Banca d’Italia sui tassi di default dal 2006;
· dati macroeconomici previsionali (PIL, tasso di disoccupazione, BTP a 2 anni, inflazione).
I primi risultati di questo esercizio indicano che il tasso d’ingresso in default del portafoglio in bonis, e il conseguente flusso annuo di nuovi NPL, sono attesi in moderato aumento. Tuttavia, i livelli previsti restano gestibili, grazie al miglioramento della qualità originaria del credito erogato e a una maggiore disciplina nei processi di origination.
In sintesi, ci troviamo di fronte a uno scenario di normalizzazione del rischio di credito, non di allarme. Dopo un lungo ciclo di miglioramento, è fisiologico attendersi un parziale riassorbimento di rischiosità, ma il sistema bancario italiano oggi affronta questa fase con fondamentali molto più solidi rispetto al passato: coperture elevate, portafogli più diversificati, una gestione attiva del credito deteriorato e strumenti più sofisticati per il monitoraggio.
All’interno di questo contesto più maturo e resiliente, anche il mercato degli NPL ha avviato una nuova fase di evoluzione. Dopo anni d’intenso de-risking, il settore si caratterizza oggi per una maggiore selettività. In un ambiente segnato da tassi d’interesse ancora elevati e da un incremento dei costi di recupero legato all’inflazione – elementi che hanno ampliato la forbice di prezzo tra domanda e offerta – si osserva un progressivo rallentamento delle cessioni, già evidente nel 2024, con una maggiore enfasi sulle azioni di recupero ordinarie. Con il progressivo esaurirsi delle grandi dismissioni primarie, la nuova frontiera dell’industria sarà rappresentata dai mercati secondari.
L’industria degli NPL continuerà dunque a rivestire un ruolo strategico nei prossimi anni, ma con una fisionomia diversa: meno centrata su operazioni di grande volume e più orientata verso gestione attiva, specializzazione, internazionalizzazione e innovazione.
Iscriviti alla newsletter: https://www.bebankers.it/newsletter/