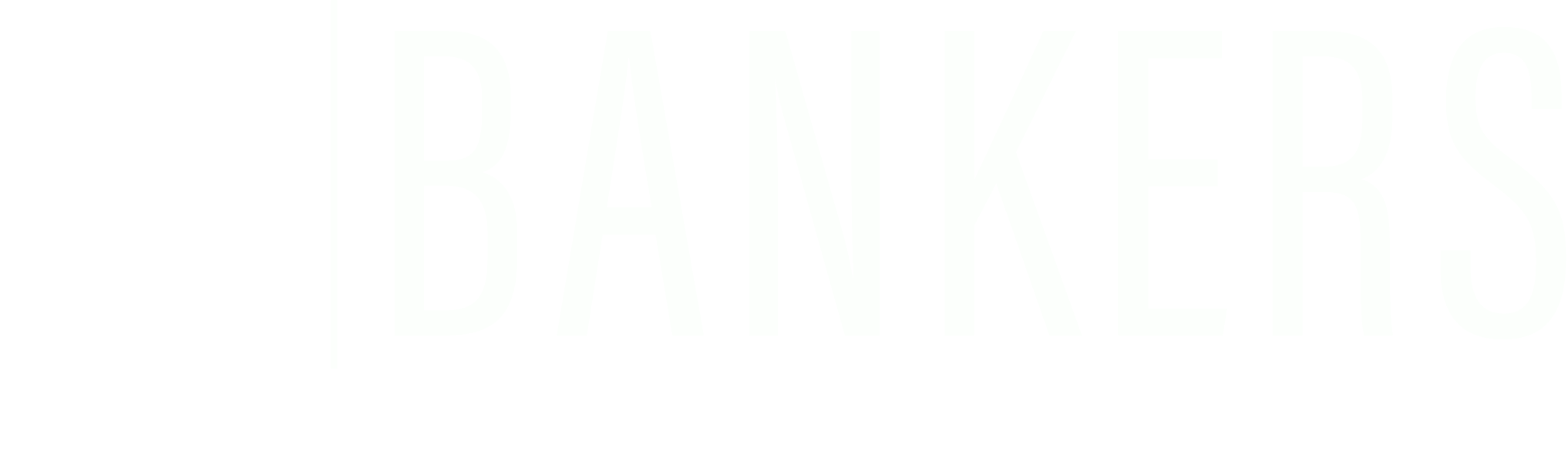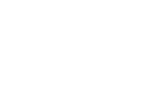Più che una svendita, è un’apocalisse industriale e occupazionale. Se fosse accolta l’offerta di acquisizione dell’Ilva avanzata ai commissari del gruppo siderurgico dal fondo d’investimento statunitense Bedrock Industries, gli effetti sarebbero devastanti.
Come segnalato da Il Sole 24 Ore, l’accettazione di quel piano comporterebbe oltre 7.000 esuberi (sui circa 8.000 occupati attuali). Gli americani, poi, vorrebbero comprare tutto a un euro. Lo Stato si troverebbe in difficoltà sui prestiti-ponte già concessi, che così non tornerebbero indietro. D’altra parte, anche la via – pur dolorosa – della cessione «a pezzi» non sembra percorribile. Ci sono, infatti, «pezzi» per cui non è stata fatta alcuna offerta. Tutto questo avviene mentre, sul fronte industriale, l’acciaio piano prodotto dall’ex Ilva sarebbe prezioso per il nostro Paese: ne consumiamo 11 milioni di tonnellate l’anno e ne produciamo solo 4.
Anche se una risposta formale deve ancora essere data, sembra difficile immaginare un «sì». E, a questo punto, appare altrettanto inevitabile un nuovo intervento dello Stato, in modalità tutte da definire. A richiederlo non sono soltanto i sindacati, ma anche Assonime, l’associazione delle società per azioni che normalmente preferisce, nelle crisi, interventi di mercato anziché quelli guidati e sostenuti dalla mano pubblica.
A questa conclusione giunge un ponderoso studio (157 pagine) che la stessa Assonime ha dedicato alla vicenda dell’Ilva, la cui crisi si è susseguita nell’ultimo mezzo secolo: da quando ancora si chiamava Finsider, a quando fu ceduta al gruppo Riva (1995) e poi a quello indiano ArcelorMittal (2015) – tutti accordi finiti in malo modo con strascichi giudiziari miliardari – sino alle gestioni commissariali che negli ultimi anni hanno cercato invano una soluzione alla crisi dell’acciaio.
In un’intervista al Secolo XIX, il direttore generale di Assonime, Stefano Firpo, ha riassunto in poche cifre la portata del disastro: «Il nostro studio ricostruisce i molteplici interventi dello Stato e le diverse voci. Siamo a oltre 3 miliardi solo per i finanziamenti tesi a garantire la gestione ordinaria, l’ingresso di Invitalia, il finanziamento soci. A questi occorre aggiungere oltre 13 milioni per coprire i crediti con l’indotto, 10 milioni per pagare i commissari, almeno 750 milioni di integrazione al reddito dei cassaintegrati. Senza contare le perdite cumulate dal gruppo tra il 2012 e oggi».
E la ricchezza perduta?
«Tra il 2011 e il 2023 – ha spiegato Firpo – la crisi dell’Ilva ha prodotto una perdita di oltre 24 miliardi del Pil, l’1,39 per cento della ricchezza nazionale. In questi anni il Sud ha perso 17 miliardi, il 4,4 per cento del suo Pil; il Nord circa 7 miliardi, lo 0,54 per cento del suo Pil».
All’origine della crisi della siderurgia italiana non c’è soltanto la politica di dumping delle aziende estere, che ha messo fuori gioco la concorrenza, ma soprattutto l’incapacità di conciliare le esigenze produttive del gruppo con la salvaguardia dell’ambiente e della salute.
Eppure, già nel 2014, il commissario straordinario Enrico Bondi aveva indicato la via da seguire: quella – ha spiegato lo studio di Assonime – dell’integrale decarbonizzazione dell’impresa, con la trasformazione del ciclo di produzione dell’acciaio dal carbone fossile al preridotto (semilavorato del ferro realizzato con gas naturale), la chiusura progressiva degli altiforni e il passaggio graduale ai forni elettrici, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni climalteranti e di tutela della salute umana.
Il piano, tuttavia, non incontrò il favore dei finanziatori e del nuovo Governo Renzi. Nel giugno 2014 il Consiglio dei Ministri nominò Piero Gnudi commissario al posto di Bondi. Da allora, la crisi si è avvitata, con un rimpallo di responsabilità che in questi anni ha coinvolto potenziali acquirenti, autorità pubbliche (nazionali e locali) e magistratura.
Iscriviti alla newsletter: https://www.bebankers.it/newsletter/