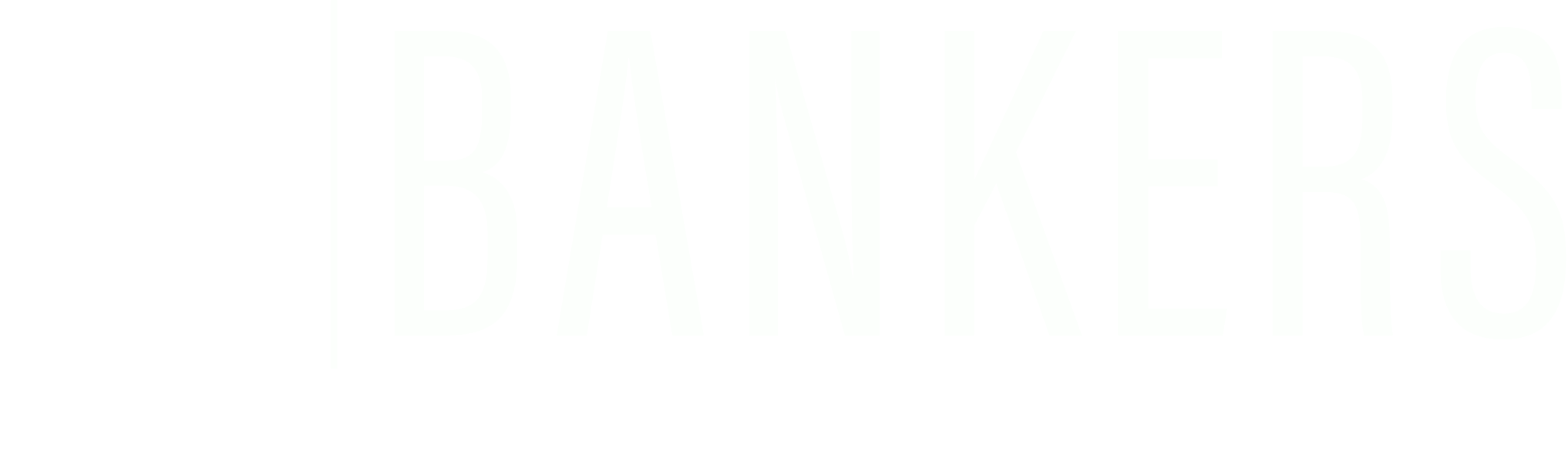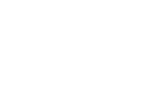Così “geniale” non sembra. La nuova normativa volta a regolamentare le stablecoin nell’ordinamento statunitense, il GENIUS Act (luglio 2025), ha introdotto elementi di forte competizione con l’impostazione fin qui seguita da altri ordinamenti e con gli stessi indirizzi suggeriti dagli organismi (ad esempio il Financial Stability Board) che normalmente svolgono il compito di smussare le distanze esistenti tra le diverse legislazioni per favorire uno sviluppo ordinato dei mercati finanziari. La forzatura imposta dalla nuova amministrazione USA, allo scopo di rafforzare il ruolo del dollaro come moneta egemone nei pagamenti internazionali, ha innescato una competizione normativa che potrebbe condurre a una frammentazione dei mercati in uno dei segmenti più innovativi della finanza mondiale. Giuseppe D’Agostino, regulator di lungo corso (per molti anni in forza alla CONSOB, dove ha occupato il ruolo di Vice-Direttore Generale) e attualmente Fintech Regulation Expert presso lo Studio Legale Bird & Bird, ha recentemente scritto un articolo con Johannes Wirtz (partner di Bird & Bird in Germania), confrontando nel dettaglio la nuova normativa USA con il Regolamento UE c.d. MiCA (2023) che ha sdoganato per l’Europa i nuovi strumenti digitali. A lui Be Bankers ha chiesto un commento sul trend in corso, valutando i tanti rischi che incombono sui mercati.
«Gli approcci degli Stati Uniti e dell’Unione Europea alla regolamentazione dei mercati crypto rivelano una divergenza strategica fondamentale. Infatti, il GENIUS Act si concentra esclusivamente sulle stablecoin di pagamento private denominate (esclusivamente) in dollari, privilegiando rapidità d’implementazione attraverso regole minime, presidi prudenziali rigorosi e supervisione articolata. Il Regolamento UE c.d. MiCA (2023, con piena applicazione dal dicembre 2024) adotta, invece, un approccio ampio e armonizzato per diverse tipologie di crypto-asset. Le divergenze tra i due lati dell’Atlantico riflettono strategie geopolitiche antitetiche: gli USA perseguono un vantaggio competitivo immediato per consolidare il predominio nei pagamenti internazionali, trasformando ogni stablecoin in estensione digitale del sistema monetario statunitense, mentre l’UE lavora a un modello potenzialmente esportabile per integrazione progressiva dei crypto-asset che non rientrano nella regolamentazione del settore finanziario nell’alveo della finanza tradizionale».
L’approccio europeo alla regolamentazione dei crypto-asset prima dello sviluppo del mercato in UE rischia di scoraggiare l’innovazione?
L’articolata architettura normativa europea, con i suoi numerosi atti di secondo e terzo livello, solleva inevitabilmente preoccupazioni sulla capacità dell’UE di mantenere competenze innovative. Tale complessità può apparire particolarmente sfidante per operatori privi di strutture di compliance consolidate. Tuttavia, MiCAR nasconde opportunità strategiche significative. Il regolamento offre agli operatori europei, specialmente agli intermediari finanziari autorizzati, la possibilità di sviluppare modelli integrati attraverso la convergenza con MiFID II e il Regime Pilota sulla Distributed Ledger Technology (DLT), la tecnologia del registro distribuito.
Questa integrazione consente di operare simultaneamente su strumenti finanziari e crypto-asset regolamentati, generando economie di scopo per chi naviga efficacemente la complessità normativa. Il framework crea un ambiente competitivo differenziato dove gli operatori consolidati beneficiano di economie di scala, mentre i nuovi entranti mantengono vantaggi di specializzazione. La sfida principale rimane nell’attrarre i grandi operatori internazionali verso la regolamentazione europea.
La divergenza tra la regolamentazione USA ed EU sulle stablecoin sembra contrastare con le raccomandazioni del Financial Stability Board (FSB) in tema di concertazione/coordinamento delle regolamentazioni e supervisory framework su stablecoin. Ma i mercati globali non presuppongono un contesto normativo omogeneo?
Questa divaricazione regolatoria tra USA ed Europa contrasta palesemente con le raccomandazioni che l’FSB ha prodotto nel 2023 e 2024, volte a favorire la convergenza di supervisione dei mercati crypto-asset, specialmente per le stablecoin sistemiche. L’FSB riconosce infatti la natura intrinsecamente transfrontaliera di queste attività e mira a evitare effetti-domino globali e contagio verso il sistema finanziario tradizionale, auspicando una copertura regolamentare di tutti i crypto-asset, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, compresi quelli operanti attraverso protocolli DeFi. Paradossalmente, sia MiCAR che GENIUS Act presentano lacune significative rispetto a queste indicazioni FSB. Entrambi i framework non contemplano, infatti, lo sviluppo di protocolli informatici, la gestione dell’infrastruttura di base, l’uso di crypto-asset come garanzia o i prestiti crypto. La sostenibilità di approcci così divergenti appare problematica, considerando che l’interconnessione crescente dell’ecosistema crypto con il sistema finanziario tradizionale potrebbe trasformare il fallimento di partecipanti chiave delle stablecoin in sfide per la stabilità finanziaria globale, esattamente il rischio che le raccomandazioni FSB mirano a prevenire. I mercati globali richiedono effettivamente un contesto normativo omogeneo, in assenza del quale le forme di vigilanza coordinata diventano largamente inefficaci.
Nel cercare d’imporre il suo predominio sui mercati dei crypto-asset, dando luogo a una competizione regolamentare tra giurisdizioni «alleate», la strategia USA non rischia di favorire una frammentazione dei mercati dannosa, alla fine, per tutti?
Le implicazioni sistemiche di questa strategia di controllo si manifestano attraverso dinamiche temporali differenziate che meritano un’analisi articolata. Nel breve termine, la divergenza regolatoria potrebbe produrre effetti di arbitraggio che favorirebbero le giurisdizioni offshore. Nel medio termine, il rischio principale sarebbe la formazione di faglie strutturali lungo i confini delle giurisdizioni.
Da un lato si svilupperebbero mercati crypto che si muovono secondo logiche di rapidità competitiva e assimilazione nei mercati dei capitali (modello USA); dall’altro, mercati caratterizzati da approcci più cauti fondati su principi di stabilità e armonizzazione (modello EU). Questa biforcazione rischierebbe di creare due ecosistemi paralleli con modalità e velocità di adattamento divergenti, pur mantenendo sistemi finanziari tradizionali che rimangono interconnessi.
Nel lungo periodo, l’assenza di convergenza potrebbe portare l’architettura finanziaria internazionale a svilupparsi in modo frammentato, con silos regolamentari differenziati e aree deregolamentate. Come sottolineato dalla BCE, questa configurazione potrebbe minare la politica monetaria dell’area euro e aprire la strada a forme invasive di arbitraggio regolamentare, aumentando i fattori non controllabili di vulnerabilità sistemica e contagio transnazionale.
Quali opzioni sono a disposizione dei regulator europei?
Nonostante l’Europa rappresenti tra un terzo e la metà dell’attività globale crypto contro il 20-25% degli Stati Uniti, la strategia americana ignora deliberatamente questa realtà per sfruttare il vantaggio strutturale del dollaro come valuta base dominante nel trading crypto mondiale. L’approccio statunitense appare chiaramente orientato verso il consolidamento di un’egemonia monetaria digitale che, sotto ai fini della sicurezza e della stabilità, mira a subordinare l’intero sistema delle transazioni crypto globali al controllo del sistema finanziario americano.
L’evidenza empirica suggerisce, dunque, che leadership USA e cooperazione internazionale potrebbero configurarsi come linee non convergenti nel contesto dei sistemi di crypto-asset (in prospettiva, parte integrante del sistema finanziario internazionale, tout court). Di fronte a questa dinamica, l’Europa si trova davanti a una scelta strategica cruciale.
L’intensificazione del sostegno agli organismi internazionali come FSB, IOSCO e IMF, rafforzandone il peso politico e la capacità di coordinamento, rappresenta l’unica via percorribile per bilanciare la spinta unilaterale americana e preservare la stabilità del sistema finanziario internazionale, mantenendo spazi d’innovazione non subordinati.
Composizione delle riserve che supportano le stablecoin: USA e UE a confronto
Le riserve fungono da collaterale nell’emissione di stablecoin per assicurare ai loro possessori di riscattare i propri token al valore nominale dichiarato. Il GENIUS Act le limita esclusivamente a strumenti del governo federale (liquidità in dollari, depositi presso la Federal Reserve Bank, titoli di Stato USA ≤93 giorni, operazioni di mercato monetario giornaliere garantite da Treasury Bills, fondi registrati USA che investono nelle categorie precedenti). Questo requisito trasforma le stablecoin in dollari e in estensioni digitali del sistema monetario statunitense.
MiCAR adotta un approccio stratificato per categorie di token. Gli e-money token richiedono composizione ibrida: 30% minimo presso istituti di credito e 70% massimo in strumenti liquidi a basso rischio nella stessa valuta del token. Gli asset-referenced token seguono un modello basato sul rischio, con flessibilità compositiva limitata a strumenti liquidi con rischio minimo (token significativi: 60% minimo in depositi per valuta). Il riferimento a “strumenti finanziari altamente liquidi a basso rischio” non limita emittente né giurisdizione. Questo significa che un e-money token denominato in dollari può investire in Treasury bonds americani, corporate bonds investment grade statunitensi o commercial paper di emittenti globali, purché rispettino i parametri di qualità.
Iscriviti alla newsletter: https://www.bebankers.it/newsletter/